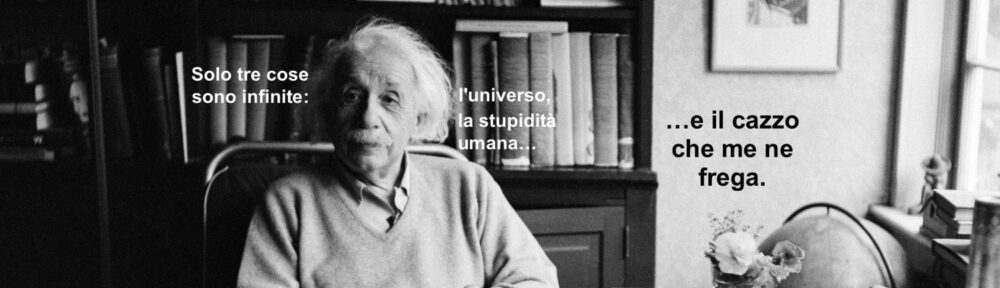Può.
Può, come qualsiasi altra attività accompagnata da un atto di riflessione su sé stessi.
La psicoterapia è stata l’esperienza più importante della mia vita. La lezione esistenziale che ne ho tratto è: «Chiediti sempre “Perché?”». Ovvero: perché ho questi pensieri/desideri/gusti, perché compio queste azioni? Ogni mia scelta, se sottoposta a indagine, diventa un’occasione per fare chiarezza su me stesso, sulle mie ragioni profonde. Facendo chiarezza, acquisisco consapevolezza. E solo con la consapevolezza posso cambiare e smettere di soffrire.
Ho iniziato a fotografare un po’ per caso, molti anni fa, con un vecchio iPhone, applicando i filtri di Instagram. Ho ottenuto anche alcuni scatti pregevoli, nei limiti dello strumento e delle mie insignificanti competenze. Poi ho smesso: altri interessi, soprattutto altre preoccupazioni.
Nel 2024 mi sono regalato una Canon entry-level: la EOS R50. Perché? Non lo so. Una fase di cambiamento nella mia vita: nuovi interessi, nuovi scopi. Mi sono detto: «Provo».
E ho provato.
Stavolta però ho studiato. Ho studiato proprio bene: lo strumento, la tecnica, i generi. Ho studiato e ho pasticciato. Ho pasticciato tanto. Nel gran pasticciare, ho fatto anche alcune foto graziose. Talune più che graziose. Foto delle quali ero molto orgoglioso. Oggi le riguardo e provo imbarazzo. Non per le foto, bensì per l’orgoglio di allora. Molto cringe, davvero.
In quelle foto mancavano tante cose. Soprattutto mancavano un gusto, un progetto, un genere. Mi piacevano tante cose: la street, la still life, il ritratto, il panorama, il minimalismo. Cercando ispirazione, osservavo le foto di altri e mi piaceva un po’ tutto e volevo imitare un po’ tutto, senza trovare una mia strada.
La prima epifania l’ho avuta quando ho scoperto la fotografia non realista, fino all’astratto. Ecco, quelle erano immagini che mi colpivano.
Certo, lo scatto sulle Dolomiti all’ora d’oro è spettacolare e mai e poi mai io sarei capace di imitarlo. Tuttavia, visto uno, – non crocifiggetemi, per favore! – visti tutti. Ho fatto scorrere sul monitor centinaia di immagini meravigliose di fiordi e montagne e foreste e cascate, ma anche di visi icastici all’altro capo del mondo. Meravigliose e soprattutto perfette sul piano tecnico. Ne ricordo al massimo quattro o cinque. Le altre anche boh.
Perché? Gusto, direi. Forse sono io superficiale, va’ a sapere. Ma sono foto che, per quanto eccellenti, non mi parlano. Non mi toccano. Non mi scuotono.
Poi, appunto, ho scoperto la fotografia non realista. Immagini volutamente imprecise, imperfette, sfocate. Anche fiordi e montagne e foreste e cascate e visi icastici, ma volutamente rovinati. Con il contrasto esagerato. Con i colori inverosimili. Con il fuoco sbagliato. E ho pensato: «Oh, cazzo!». Finalmente un’emozione, una scossa. Era quello che volevo.
Da cui la prima comprensione psicoterapeutica: la realtà non mi garba punto così come è.
Sicché ho cominciato a fotografare in quel modo: ICM, sfocature, filtri strani sull’obiettivo, sovrapposizioni. E i risultati mi piacevano. Cazzo, se mi piacevano. Finalmente producevo qualcosa che mi dava soddisfazione, che potevo mostrare ad altri senza vergognarmi. Infatti, anche di fronte a una critica, sapevo che cosa rispondere. Dietro ogni scelta stilistica c’era un pensiero consapevole.
La seconda epifania l’ho avuta quando ho compreso quale caratteristica era comune a tutte le foto, mie o altrui, che mi emozionavano: il contrasto. Contrasto sia luminoso sia cromatico.
Tante mie foto erano caratterizzate da un contrasto intenso, oltretutto rafforzato in post-produzione. Neri impenetrabili e alte luci esagerate. Colori complementari saturati, spesso molto simili nell’accoppiamento: turchese e cobalto contro giallo, arancio e rosso.
Da cui la seconda comprensione psicoterapeutica: io amo gli estremi. Del resto è coerente con la mia vita. Io potrei essere solo comunista o fascista, ateo o bigotto. (Per la cronaca: sono comunista e ateo, ma questo non c’entra.)
Così facendo, ho trovato la mia cifra stilistica: irrealtà e contrasto. E poi?
E poi basta. What else?
Invece no. Invece non si può fotografare a cazzo la qualunque. Meglio: si può, ma rimane un’attività così, un po’ campata per aria. Ci sta, eh. Ma non mi basta. Non più.
Perciò, sottoposto anche alla critica costruttiva di persone più competenti ed esperte di me, mi sono accorto di una mancanza in tutte le mie foto: la coerenza fra loro. Coerenza sia di forma sia di argomento, al di là dell’irrealtà e del contrasto. Fino a quel momento avevo scattato tante foto – alcune anche belle, alcune anche molto belle – ma accostate un po’ ad minchiam. Non c’era un filo conduttore. Non c’era un progetto.
E quindi?
Quindi ho fatto un progetto. Che ci vuole?
Molto, ci vuole, cazzo. Molto.
Sicché a posteriori ho cercato di trovare il progetto fra le mie fotografie già scattate. Insomma mi sono detto: se ho capito come mi piace fotografare riconsiderando quello che ho già fatto, forse posso capire pure che cosa mi piace fotografare sempre riconsiderando quello che ho già fatto.
Dunque che cosa mi piace?
Ho ripreso in mano i miei scatti e mi sono accorto che in molti casi – ma non tutti – il tema era lo stesso: il silenzio, la distruzione, l’abbandono. Soprattutto l’assenza umana. Se c’era, l’elemento umano era marginale. Se c’era, l’elemento umano era un simulacro. Ed era vero sia per molte foto naturalistiche sia per molte con soggetti artificiali: mai l’umano.
Le mie foto senza umani trasmettevano tristezza. Suscitavano un senso di depressione.
Perché? Boh. Non mi sento particolarmente depresso. Attenzione: parlo di depressione non in senso generico bensì con cognizione di causa della malattia, perché ci sono passato e purtroppo so che cos’è. Ma non è adesso il caso: sto bene, sono sereno. Eppure mi sento attratto, affascinato, emozionato da quelle atmosfere livide, cupe, violente, tristi e sì, deprimenti. Ma il perché non importa: quello mi piace fotografare, quello mi piace estrarre dalle immagini quando le post-elaboro.
Si può costruire un progetto fotografico a posteriori?
Si può.
Non si dovrebbe, ma si può. Se quel progetto diventa anche uno strumento per comprendere meglio sé stessi, si può.
Di solito il processo è opposto: si decide prima che cosa si vuole e come si vuole fotografare (quali soggetti, in quale forma, con quali strumenti) e poi ci si mette in caccia. Invece io sono partito dal materiale pregresso e ho definito il progetto a posteriori.
«Livid Doom» è nato così: una scoperta di un’estetica, di uno stile e di un argomento che già erano dentro di me e che solo la pratica fotografica, a mia insaputa, mi ha permesso di estrarre. Solo quando è uscita ho riconosciuto l’estetica, l’ho accolta e ho compreso come interpretarla sul piano psicologico.
«Livid Doom» è nato così ma non è ancora concluso. Adesso la linea è definita, esplicita, consapevole. Ora posso scattare non più mosso soltanto dalle mie pulsioni inconsce, ma cercando il soggetto, l’effetto e lo stile in modo consapevole, funzionale e coerente con il progetto. La fotografia prima e in particolare «Livid Doom» poi hanno agito come una psicoterapia.
E il resto? Rimane e rimane. E non è detto che non ne nascano altri progetti.